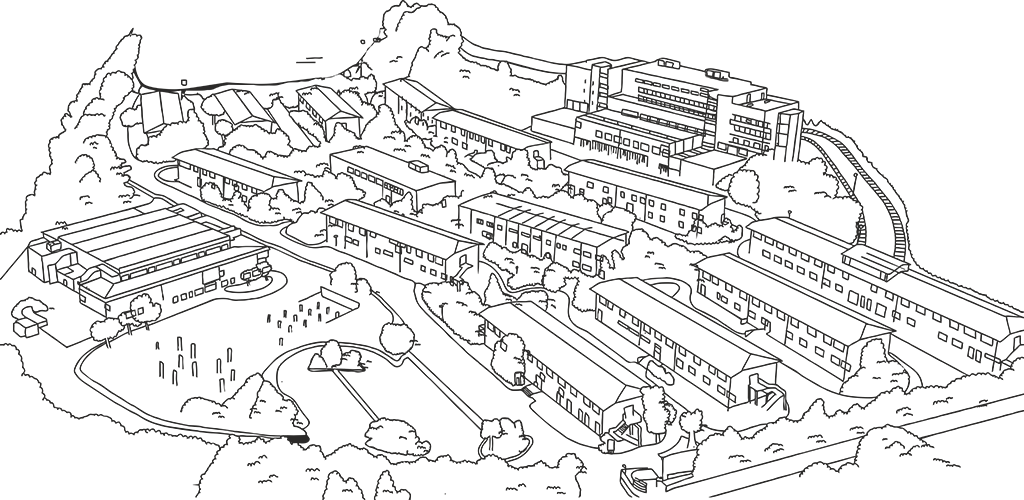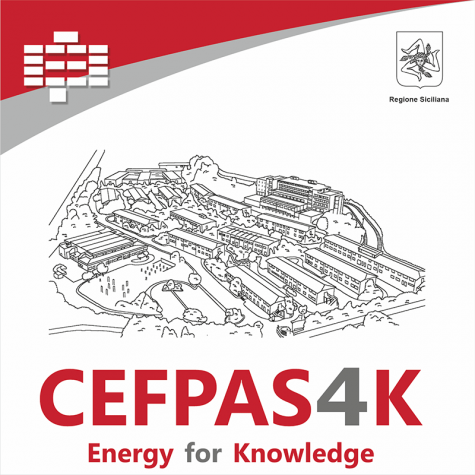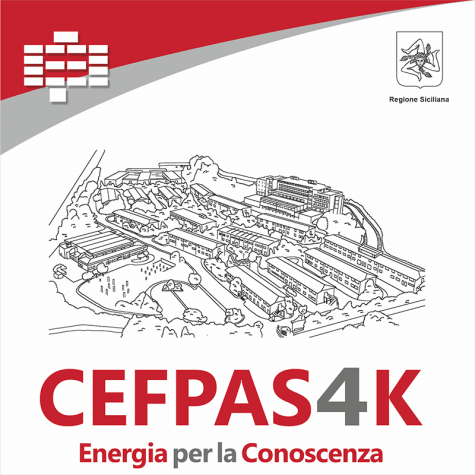Lo scorso 25 giugno ha avuto luogo al CEMEDIS, il Centro di Simulazione del CEFPAS, il Corso “Riconoscimento e diagnosi precoce dei segnali di abuso e maltrattamento sui minori” con l’obiettivo di fornire gli strumenti diagnostici (in termini di osservazione, valutazione clinica e medico legale) ed i relativi indicatori comportamentali e fisici per avviare il corretto iter di segnalazione ai servizi competenti, al fine di migliorare la diagnosi precoce dei minori vittime di abuso e/o maltrattamento. Due delle docenti sono state Anna Maria Cannata, Psicologa psicoterapeuta Referente dei Consultori Familiari dell’ASP di Palermo per l’EIAM (Equipe Interistituzionale contro l’Abuso e Maltrattamento ai minori) e la pediatra Francesca D’Aiuto, direttore della Unità Operativa Semplice “Pediatria d’Urgenza” presso l’Unità Operativa Complessa MCAU (Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza) Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina” di Palermo, che abbiamo intervistato.
Anna Maria Cannata, Psicologa psicoterapeuta Referente dei Consultori Familiari dell’ASP di Palermo per l’EIAM
Intervista ad Anna Maria Cannata
Qual è stata l’importanza del Corso “Riconoscimento e diagnosi precoce dei segnali di abuso e maltrattamento sui minori” che si è svolto al CEFPAS?
Si è trattato di un corso innovativo per l’utilizzo della metodologia della simulazione nel campo specifico della rilevazione dell’abuso e maltrattamento ai minori, metodologia che, com’è noto, è molto efficace nel facilitare l’apprendimento attraverso il coinvolgimento diretto dei partecipanti in un’esperienza immersiva verosimile ed emotivamente pregnante. Ritengo molto importante, inoltre, che una fascia sempre più ampia di operatori sanitari possa effettuare una formazione specifica sulle caratteristiche dell’abuso e maltrattamento ai minori e dei suoi effetti a breve e a lungo termine, acquisendo gli strumenti utili alla rilevazione.
Come riconoscere precocemente i segnali di abuso e maltrattamento sui minori che spesso avvengono in luoghi che dovrebbero essere sicuri come la propria casa o la scuola?
La premessa perché sia possibile riconoscere i segnali di abuso e maltrattamento ai minori è essere consapevoli che si tratta di un fenomeno diffuso, trasversale, sommerso, sottostimato. È necessario, inoltre, superare una visione superficiale e rassicurante secondo la quale è un fenomeno circoscritto ad ambienti sociali disagiati, che non ci riguarda direttamente. Il riconoscimento passa attraverso la conoscenza del fenomeno e il superamento delle resistenze psicologiche che gli stessi operatori possono, inconsapevolmente, mettere in campo. La difficoltà a rilevare i segnali di abuso e maltrattamento è connessa, inoltre, al segreto a cui si accompagna, in particolare quando esso si realizza in ambito intrafamiliare e perifamiliare. I contesti in cui il bambino e l’adolescente instaurano le relazioni più significative sono quelli in cui avvengono la maggior parte degli abusi e dei maltrattamenti. Proprio il fatto che la violenza sia perpetrata da figure di riferimento affettivo rende l’esperienza particolarmente traumatica e determina dei gravi danni psicologici a breve e lungo termine.
Abuso e maltrattamento sono spesso fenomeni “sommersi”. In che modo gli operatori sanitari possono dare il loro prezioso contributo per fare emergere e contrastare gli abusi sui minori?
Innanzitutto è necessario ricordare che la violenza sui minori costituisce un problema di salute pubblica e che tutti noi adulti siamo chiamati a proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza. Gli operatori che svolgono compiti sociali, sanitari ed educativi hanno una responsabilità ulteriore e specificamente connessa al loro mandato professionale. Gli operatori sanitari, in particolare quelli impegnati nei servizi per le urgenze/emergenze, si trovano in una posizione privilegiata in quanto, soprattutto nei casi più gravi, spesso sono i primi ad avere l’opportunità di rilevare i segnali che fanno ipotizzare che quel bambino sia vittima di abuso e maltrattamento. Il riconoscimento precoce di questi segnali può segnare la differenza nella vita di quel bambino, avviando il necessario iter per la sua protezione e per la sua presa in carico multidisciplinare. La conoscenza del fenomeno e la consapevolezza della sua gravità costituiscono le premesse per poterlo rilevare e contrastare precocemente. La costruzione di reti multiprofessionali integrate che mettano in connessione gli operatori e i servizi impegnati a diverso titolo a favore dei minori maltrattati e la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria costituiscono, inoltre, strumenti fondamentali per una presa in carico efficace nelle diverse fasi dell’intervento, dalla rilevazione alla protezione alla cura.
Quali sono, in particolare, gli aspetti psicologici legati all’abuso e al maltrattamento sui minori nell’ambito del nucleo familiare?
Le famiglie in cui avvengono abusi e maltrattamenti ai minori sono famiglie multiproblematiche che non sempre giungono all’attenzione dei servizi a causa della difficoltà a rilevare il fenomeno e a causa della segretezza che lo caratterizza. Nella maggior parte dei casi, i genitori sono stati a loro volta vittime di gravi esperienze sfavorevoli infantili, a seguito delle quali hanno sviluppato modelli genitoriali fortemente disfunzionali. Ancora impegnati psicologicamente dagli esiti della loro difficile infanzia, spesso non riescono a riconoscere i bisogni dei figli, ad empatizzare con loro ed a prendersene cura adeguatamente, fino a mettere in atto comportamenti francamente pregiudizievoli per la loro salute psicofisica.
La presenza di violenza domestica è un indicatore di grande importanza che necessita sempre di un approfondimento. Laddove una madre subisce violenza da parte del partner, il figlio è vittima di violenza assistita, fenomeno la cui gravità è ancora oggi sottovalutata. Dietro la violenza domestica/assistita spesso vi sono altre forme di maltrattamento di cui il bambino è vittima. Nei casi di abuso sessuale la dinamica intrafamiliare ha delle caratteristiche specifiche che sono così sintetizzabili: vi è un impulso nell’abusante ad erotizzare il rapporto con il bambino, un deficit nel controllo di questo impulso, un atteggiamento passivo dell’altro genitore potenzialmente protettivo, una relazione patologica nella coppia genitoriale, una relazione di dominanza psicologica dell’abusante nei confronti del bambino. L’abuso sessuale difficilmente si configura come un atto violento in senso stretto, piuttosto, è una lenta azione di manipolazione e seduzione che esercita un effetto confusivo, destabilizzante e pervasivo sul bambino vittimizzato, tanto più grave quanto più precoce e duratura.
Qual è l’iter da seguire per la segnalazione dell’abuso in età evolutiva?
L’iter è quello stabilito dalla legge (art. 331 c.p.p. “Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio” e art. 334 c.p.p.). Laddove vi siano dei segnali di abuso o maltrattamento – come una rivelazione esplicita da parte del minore, un insieme di indicatori fisici/psicologici/comportamentali/relazionali nel bambino e nei caregivers – l’operatore sanitario, che nello svolgimento del suo lavoro è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ha l’obbligo di presentare la denuncia all’Autorità Giudiziaria (A.G.). Sarà l’A.G. a svolgere le indagini per l’accertamento dei fatti. La denuncia è obbligatoria per tutte le ipotesi di reato perseguibili d’ufficio (quelle di abuso e maltrattamento ai minori rientrano in questa fattispecie) e la mancata denuncia si configura come un reato.
Vi sono ancora oggi delle resistenze da parte degli operatori a segnalare/denunciare, nonostante vi sia una maggiore conoscenza del fenomeno dell’abuso e maltrattamento e dei suoi gravi effetti. A volte l’operatore teme di esporsi troppo su un piano individuale, di essere coinvolto nel procedimento giudiziario o di causare dei danni alle famiglie denunciando un abuso/maltrattamento che poi si riveli falso. La conoscenza del fenomeno e la consapevolezza del danno a lungo termine che un abuso/maltrattamento non rilevato e non denunciato può causare nel bambino devono sostenere il superamento delle resistenze a seguire l’iter previsto dalla legge. Inoltre, la possibilità di lavorare in équipe multidisciplinari, condividendo con i colleghi la rilevazione dei segnali di abuso e maltrattamento e la segnalazione all’A.G., costituisce un’importante risorsa in aiuto degli operatori.
Quale scenario, tra quelli riprodotti durante il corso in simulazione del CEMEDIS, si è prestato particolarmente per il raggiungimento degli obiettivi didattici?
Gli scenari proposti erano due, uno riguardava l’intervento dell’équipe del 118 a domicilio, il secondo proponeva un caso giunto all’attenzione del personale del Pronto Soccorso. Entrambi hanno offerto ai partecipanti degli spunti esperienziali e conoscitivi molto interessanti che sono stati oggetto di confronto nella fase di debriefing e che probabilmente non sarebbero emersi con la stessa pregnanza se il corso fosse stato esclusivamente teorico. La riflessione successiva agli scenari è stata molto utile a focalizzare l’attenzione sull’impatto emotivo delle due situazioni sui partecipanti e sulle conseguenze di questo sul loro intervento. Ciò ha facilitato un processo di presa di consapevolezza emotivo-cognitiva e la formulazione di ipotesi operative alternative da mettere in pratica in situazioni analoghe. Molto importante, a mio parere, è stata la condivisione da parte dei partecipanti della necessità di sviluppare la capacità di ascolto del minore come punto di partenza per qualsiasi intervento a suo favore.
Francesca D’Aiuto, direttore Unità Operativa Semplice “Pediatria d’Urgenza” presso l’Unità Operativa Complessa MCAU Pediatrica Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina” di Palermo
Intervista a Francesca D’Aiuto
Qual è il ruolo degli operatori sanitari delle strutture per l’emergenza (pronto soccorso e SUES 118) nel prestare soccorso al minore vittima di maltrattamento fisico e psicologico?
Il maltrattamento sui bambini, pur molto diffuso, è un fenomeno ancora poco conosciuto dagli operatori titolati a contrastarlo. Medici e infermieri, in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in presenza di un sospetto maltrattamento o abuso su minori, hanno l’obbligo di legge di denunciare e, ancor di più, in quanto responsabili della salute dei minori, hanno l’obbligo morale di proteggere i più piccoli. Riconoscere e segnalare precocemente una potenziale situazione di maltrattamento può prevenire ulteriori abusi su un minore e garantirgli la protezione necessaria. In area di emergenza le difficoltà non mancano: i ritmi frenetici, i tempi ridotti, gli spazi inadeguati, i contatti con i pazienti fugaci. I segnali che inducono al sospetto, inoltre, non sono sempre facili da rilevare e medici e infermieri hanno una formazione inadeguata o insufficiente in materia. Per tutti questi motivi, nonostante obbligo di legge e morale, i sanitari riconoscono poco i maltrattamenti e, ancor meno, li segnalano. Eppure il Pronto Soccorso e il 118 hanno un ruolo centrale nell’identificare le situazioni di violenza nei confronti dei bambini.
Cosa deve fare quindi in un simile contesto, un operatore delle emergenze per soccorrere una vittima di abuso? In primo luogo, non escludere la possibilità di trovarsi davanti a un minore vittima di maltrattamento o abuso, porre l’attenzione ai segnali di sospetto (cosiddetti “indicatori”), avere la certezza che bisogna lavorare in rete poiché la diagnosi è sempre multidisciplinare. L’obiettivo non deve mai essere quello di fare indagini o cercare un colpevole, piuttosto di identificare una condizione di rischio e proteggere il minore. Il ruolo degli operatori sanitari dell’emergenza dunque è quello di intercettare ogni situazione di violenza, reale o potenziale, nei confronti dei bambini, accogliere, proteggere, rilevare, curare, accompagnare, segnalare e attivare la rete. Un ruolo davvero impegnativo, delicato e complesso che prevede tempestività, alto grado di professionalità, gestione della emotività e competenza specifica.
Durante il corso, lei ha presentato il PDTA sull’abuso in età evolutiva, cosa prevedono le linee di indirizzo del percorso diagnostico assistenziale?
Durante il corso ho avuto modo di presentare alcuni esempi di PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali) su maltrattamento e abuso nei confronti di minori: quelli delle regioni Lombardia, Emilia Romagna, di alcuni ospedali romani e torinesi. Particolare attenzione ho riservato al PDTA “Gestione in Pronto Soccorso dei minori vittime di maltrattamento e abuso” dell’ARNAS Civico di Palermo, azienda in cui svolgo il mio servizio. Il PDTA, approvato il 29/12/2022, dopo un lungo e fruttuoso lavoro di confronto multidisciplinare, è testimonianza concreta di una sempre viva sensibilità e attenzione dell’Azienda Civico e del PS dell’Ospedale di Bambini, in particolare, nei confronti del tema. Rappresenta un esempio virtuoso di percorso condiviso atto a fornire elementi diagnostico-assistenziali per il riconoscimento, la cura e la corretta presa in carico dei minori vittime di maltrattamento e abuso che accedono presso l’Ospedale pediatrico “G Di Cristina”, mediante un approccio multidisciplinare.
L’obiettivo è: garantire ai minori vittima di maltrattamento/abuso un percorso protetto in Pronto Soccorso; fornire a tutti gli operatori coinvolti nel percorso riferimenti chiari e precisi sulle fasi di responsabilità e gli obblighi normativi, in modo da aumentare la consapevolezza professionale con la formazione continua; uniformare i comportamenti professionali riducendone la variabilità; incrementare la qualità dell’assistenza percepita ed effettivamente erogata; migliorare gli esiti e promuovere la sicurezza del paziente attraverso l’utilizzo delle giuste risorse; implementare il coordinamento tra Ospedale, Forze dell’Ordine, Servizi Sociali, pediatria di famiglia, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario. I PDTA servono per delineare con precisione modalità, tempistiche e sequenza di procedure, ovvero un percorso diagnostico e terapeutico non solo efficace e tempestivo, ma condiviso, che implichi la partecipazione di tutte le figure necessarie, redatto alla luce di tutte le evidenze scientifiche sull’argomento e tenendo conto del contesto reale e delle risorse locali disponibili. Il paziente coinvolto in un PDTA avrà dunque la certezza di essere seguito con continuità, secondo protocolli già identificati come ottimali e ampiamente condivisi. L’auspicio è che, superando un’ottica puramente aziendale, anche la Sicilia abbia, al più presto, un PDTA regionale unico e condiviso per la gestione dei minori vittima di maltrattamento e abuso, applicabile in tutti i possibili setting assistenziali e che coinvolga tutti i sanitari, dal territorio all’ospedale.
Quali sono le strategie più efficaci, in questi casi, per comunicare con le vittime di violenza e con le famiglie?
Così come durante il corso di studi per i sanitari non è prevista una formazione specifica su maltrattamento e/o abuso, allo stesso modo noi sanitari non siamo adeguatamente formati a comunicare con i pazienti e le famiglie. Eppure una comunicazione efficace sia verbale sia non verbale è una competenza fondamentale per la nostra professione. La comunicazione inizia con l’ascolto, che, riconoscendo dignità al trauma, costituisce anche un primo intervento di riparazione del danno. Il mancato ascolto è tossico. L’interesse e l’attenzione al minore si manifestano già nell’attenzione alla disposizione spaziale: i sanitari dovrebbero parlare direttamente con il minore, anche, qualora possibile, in assenza dei genitori o, comunque, senza interposizione fisica del genitore o accompagnatore (un consiglio semplice, ad esempio, è far stare eventuali accompagnatori alle spalle del minore, invitandoli a non intervenire durante l’intervista). Il racconto dell’accompagnatore, invece, dovrebbe avvenire in assenza del minore.
Per una corretta comunicazione è, inoltre, necessario un atteggiamento corretto, mai giudicante o accusante, ma accogliente: non scartare subito l’ipotesi di maltrattamento e/o abuso, non avere fretta, non giudicare, non fare domande “chiuse”, suggestive, non palesare eventuali sospetti, evitare di porre domande dirette, prestare attenzione alla formulazione delle domande affinché non contengano implicitamente le risposte attese, non interrompere il bambino, ridurre la necessità che ripeta più di una volta il racconto e i dettagli, utilizzare un linguaggio semplice, comprensibile al bambino, credere sempre a ciò che egli dice e fargli capire che gli crediamo, rassicurarlo, spiegandogli che non è responsabile e non ha colpe, mostrarci contenti che ci stia raccontando l’accaduto, ma dispiaciuti per ciò che gli è capitato e comunque disposti ad aiutarlo. Prima di visitare il bambino e durante tutte le fasi di accoglienza e presa in carico, chiedere sempre il consenso del minore e coinvolgerlo spiegandogli ogni passaggio e le modalità dell’eventuale visita.
Uno degli aspetti che lei ha trattato durante l’attività formativa è stato quello della Shaken Baby Syndrome, di cosa si tratta?
La Shaken Baby Syndrome (SBS) è una grave forma di maltrattamento fisico, prevalentemente intrafamiliare, ai danni di bambini generalmente sotto i 2 anni di vita, che si verifica quando un neonato o un lattante viene scosso violentemente dal caregiver, come reazione al suo pianto inconsolabile. Il picco di incidenza si ha tra le 2 settimane e i 6 mesi di vita, che è proprio il periodo di massima intensità del pianto del lattante. In questa fase di sviluppo le caratteristiche del neonato e del lattante (debole muscolatura del collo, mancato controllo del capo, sproporzione tra capo e corpo, maggiore quantità di acqua contenuta nell’encefalo e minore mielinizzazione, cervello più gelatinoso, facilmente comprimibile e deformabile dentro il cranio) lo rendono particolarmente vulnerabile all’azione di scuotimento e alle forze di accelerazione, decelerazione e rotazione conseguenti allo scuotimento. Quando si scuote un bambino il capo si sposta violentemente avanti e indietro, la testa e il cervello subiscono forze di accelerazione e decelerazione che causano l’impatto dell’encefalo contro le ossa con danno lacero-contusivo dell’encefalo, sanguinamento o rigonfiamento (edema, stiramento o lacerazione dei vasi sanguigni), danno degli organi addominali. Le conseguenze estreme sono emorragie intracraniche, lesioni delle fibre nervose, emorragie retiniche, fratture multiple del cranio fino al coma e alla morte.
Sotto il profilo clinico la SBS rientra nell’ampia categoria dell’Abusive Head Trauma (Trauma Cranico da Abuso). Lo scuotimento comporta una serie di lesioni gravi che hanno conseguenze devastanti sulla vittima. A seconda di chi è l’autore dello scuotimento, diverse sono le ragioni alla base dell’agìto. Spesso le cause sono riconducibili a fragilità emotiva/psicologica dei genitori dato lo stress prolungato e/o stati di instabilità quali depressione post partum. La figura più vulnerabile è in genere il genitore a contatto più prolungato con il piccolo ed esposto più a lungo al suo pianto. Non c’è di solito premeditazione trattandosi di un gesto impulsivo, anche se ripetuto.
Quali sono i possibili sintomi della Shaken Baby Syndrome e come si può prevenire?
Ancora troppo poco conosciuta in Italia, la Shaken Baby Syndrome in un caso su quattro conduce al coma o alla morte dei lattanti. In un caso su tre, invece, sviluppa sintomi meno gravi o esiti non ben definiti. Tra le conseguenze anche a lungo termine: disturbi dell’apprendimento, disturbi cognitivi, disturbi comportamentali, attacchi epilettici, ritardo nello sviluppo psicomotorio, cecità, diplegia spastica (paralisi di entrambi i lati), tetraplegia (paralisi di tutti e quattro gli arti). La SBS è una condizione intercettata in modo trasversale, molto complessa da diagnosticare. I sintomi di presentazione possono essere molto aspecifici: sonnolenza, irritabilità, pianto, anoressia, vomito, crisi epilettiche, apnea, deficit neurologici, macrocrania (aumento della circonferenza cranica), lesioni addominale. Eppure è facilmente prevedibile.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha richiamato la necessità di adottare strategie di prevenzione e di sviluppare programmi efficaci e consapevoli. Si può prevenire, infatti, solo ciò che si riconosce. Bisogna promuovere nuove sensibilità, una maggiore responsabilità formativa e culturale dei professionisti, rafforzare il lavoro di rete e la diffusione di un linguaggio universale. Con tale finalità dal 2017 è stata lanciata la campagna “Non scuoterlo” e il 7 aprile di quest’anno, per la prima volta, la SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza Pediatrica) con Terres des Hommes, ha organizzato la prima giornata di prevenzione dedicata alla Shaken Baby Syndrome, che si è svolta in oltre 30 città italiane. È necessario parlarne perché la SBS colpisce vite (bimbi tra 0 e 2 anni) che possono trovare protezione solo grazie all’attenzione e alla cura degli adulti, in quanto prive di strumenti propri di difesa. È necessario creare una coscienza diffusa. Effondere tra i genitori la consapevolezza dei gravi danni che possono essere inferti a un bambino con lo scuotimento e al tempo stesso invitarli a chiedere aiuto quando il pianto del bambino, in alcune fasi dello sviluppo particolarmente intenso, diventa fonte di stress e nervosismo tali da poterli indurre a manovre consolatorie poco accorte. In conclusione, la scelta di inserire questo argomento nel corso rimarca l’urgenza di diffonderne la conoscenza in ogni ambito, perché solo da un’alleanza tra il territorio e il mondo ospedaliero può attivarsi una risposta qualificata e tempestiva al fenomeno.
La simulazione di casi reali si presta come metodologia formativa per il trattamento di questa tematica. A suo avviso quale impatto ha avuto nei corsisti la partecipazione allo scenario sul riconoscimento e sulla diagnosi precoce dei segnali di abuso e maltrattamento sui minori?
Dopo un breve confronto teorico i partecipanti al corso hanno avuto modo di sperimentare in prima persona l’approccio in team al bambino vittima di maltrattamento/abuso. Abbiamo ricreato scenari verosimili di sospetti maltrattamenti o abusi, domestici (per sanitari del 118) o di Pronto Soccorso, basati su casi realmente vissuti da alcuni di noi e che hanno creato difficoltà di gestione. I partecipanti hanno così testato quanto appreso, in un clima non giudicante. Nel momento di confronto successivo, il “debriefing”, grazie alla sapiente guida di facilitatori in simulazione (psicologi e medici), hanno avuto inoltre occasione di riflettere sull’esperienza vissuta, rivedendola in modo critico e costruttivo così da investigare le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti che hanno condotto alle azioni osservate, rielaborarle e imparare da eventuali “errori” (scostamenti tra le azioni osservate e quelle previste). La simulazione risulta utilissima per imparare a gestire scenari rari, come maltrattamenti e abusi sui minori, per i quali la sola esperienza clinica è insufficiente ad acquisire competenze adeguate.
Il classico insegnamento basato sulla modalità “vedo e apprendo”, sempre più messo in discussione per lo scarso coinvolgimento e per le motivazioni etiche di protezione dei pazienti (il paziente non può mai essere “strumento didattico”), è stato superato dalla simulazione che, anche in questa esperienza, si è dimostrata efficace garantendo il coinvolgimento dei partecipanti in assenza di rischi per il paziente, nel rispetto di un obiettivo etico prioritario: mai la prima volta sul paziente, al fine di ridurre gli errori medici. La simulazione ha infine permesso di esercitarsi nel lavoro di gruppo con la possibilità di valutare al meglio la comunicazione, i processi decisionali, le dinamiche di una situazione critica e la gestione delle risorse (leadership, team building, problem solving) integrando le conoscenze teoriche con le capacità pratiche.
L’intervista è stata realizzata da Ilenia Inguì, Dirigente del Servizio Comunicazione del CEFPAS.
L’articolo Riconoscere precocemente i segnali di abuso e maltrattamento nei bambini: l’intervista ad Anna Maria Cannata e Francesca D’Aiuto proviene da CEFPAS | Centro di Formazione Sanitaria.